mercoledì, 28 febbraio 2007
EVERYMAN di Philip Roth
Giorni fa, all’interno di una libreria romana, ho avuto modo di chiacchierare del più e del meno con un simpatico libraio. Nel corso della conversazione il mio sguardo si è posato sulla copertina nera del più recente libro di Philip Roth: Everyman, pubblicato in Italia da Einaudi.
Ho preso in mano il volume e, rivolgendomi al libraio, ho commentato: “Bello,eh?”
Il libraio ha fatto spallucce. “Sarà pure bello” mi ha detto. “Solo che non ce l’ho fatta proprio a finirlo. Sa, sto uscendo dalla morte di mia madre. Se ne è andata pochi giorni fa.”
Ho annuito. E ho compreso la scelta di interrompere la lettura del libro.
Ha ragione il libraio. Questo libro di Roth è uno di quelli che colpisce duro. Come un pugno allo stomaco. E mano a mano che si procede nella lettura il colpo subìto si avverte in misura crescente. Tuttavia credo che di colpi così ne abbiamo bisogno. Soprattutto oggi, in un’epoca in cui – pare – non riusciamo più a guardarci davvero in faccia e a confrontarci con il limite principale della nostra condizione umana: la morte.
Copertina nera, si diceva. Molto elegante. Ed è ovvio che la scelta della copertina non è da attribuire solo a ragioni estetiche. C’è il richiamo al colore che meglio identifica il trapasso, la dipartita. Quel neromorte che, prima o poi, è chiamato ad avvolgere tutto. E tutti.
Peraltro, come si legge sulla prima delle bandelle laterali «Everyman prende il titolo da un’anonima rappresentazione allegorica quattrocentesca, un classico della prima drammaturgia inglese, che ha per tema la chiamata di tutti i viventi alla morte».
Il protagonista del libro è un pubblicitario di successo presso un’agenzia di New York. La sua vita privata è piuttosto travagliata: sposato tre volte (con donne che non si somigliano per nulla); ha tre figli di cui due dalla prima moglie e una dalla seconda; ha un fratello che è un uomo ricco e di successo (ma molto amorevole) per il quale proverà una disdicevole invidia. Ma le peculiarità della vita di questo man, in fin dei conti, sono solo dettagli. Insignificanti, direi. Soprattutto se visti con l’ottica della nostra comune precarietà esistenziale. Non è un caso che il nome del protagonista non è mai citato nel libro. Potrebbe essere chiunque. Potrebbe essere ogni uomo, appunto, al di là dei piccoli elementi distintivi di una singola storia. E dunque il fatto che il nome di questo personaggio non venga reso noto al lettore sembra una scelta naturale e opportuna. Del resto Roth è bravissimo a misurare il racconto e a equilibrare i rapporti tra i personaggi in guisa tale che l’assenza del nome del protagonista non pesi.
La narrazione procede per salti temporali. Roth inizia con il raccontare (o meglio, con il mostrare) il funerale dell’uomo. E già dalle prime pagine, per alcuni versi toccanti, è possibile percepire un’asprezza realistica che esprime un disincanto quasi cinico: “In tutto lo stato, quel giorno, si erano celebrati cinquecento funerali come il suo, altrettanto di ordinaria amministrazione, e tolti i trenta recalcitranti secondi della scena dei figli (…), né più né meno interessante di tutti gli altri.”
La morte fa capolino molto presto nella vita del protagonista. Da ragazzino, per esempio; allorquando si trova in ospedale per via di un’ernia inguinale che richiede l’intervento chirurgico. Il suo compagno di stanza è un ragazzo in stato terminale. E all’attesa della dipartita del ragazzo si accompagnano ricordi funesti: “All’inizio non prese sonno perché aspettava che il ragazzo morisse, e poi non prese sonno perché non poteva smettere di pensare al corpo dell’annegato gettato sulla spiaggia l’estate prima.”
Il pensiero della morte incombe sull’uomo a fasi alterne. A volte pare sparire, per poi ripiombare d’improvviso anche quando il contesto esistenziale ne giustificherebbe il rigetto: “Perché doveva diffidare della propria vita proprio quando ne era più padrone di quanto lo fosse stato in anni e anni? Perché doveva immaginarsi sull’orlo dell’estinzione quando un semplice e calmo ragionare gli diceva che davanti c’era tant’altra vita stabile e piena? (…) Ho trentaquattro anni! Comincia a preoccuparti dell’oblio, diceva tra sé e sé, quando ne avrai settantacinque!”
Ma la storia di Everyman non è solo la storia di una vita destinata a spegnersi. È anche storia di malattie, cronaca dettagliata e cruda di un deperimento fisico progressivo e inesorabile che degenera ineluttabilmente fino all’oblio.
Il protagonista si ammalerà di appendicite degenerata in peritonite nel 1967, ripercorrendo il destino del padre (ammalatosi di appendicite e peritonite nel 1943) e dello zio (che ne era morto a 19 anni).
E poi dovrà fare i conti con seri problemi cardiologici, con un’ostruzione nell’arteria renale, con un’operazione nella carotide sinistra per ostruzione di una delle due arterie principali, con l’applicazione di un defribillatore all’interno della gabbia toracica. Ma nonostante questo andrà avanti, sebbene, “… non aveva ancora settant’anni quando la sua salute cominciò a declinarsi e il suo corpo a indietreggiare davanti alle continue minacce.”
Eppure, anche nella tragedia, pur nella trattazione del male umano supremo, quest’opera non manca di punte di autoironia e tragicomicità come si può evincere dal passo che segue: “La moglie del momento – la terza e ultima – non aveva la minima rassomiglianza con Phoebe e anzi, a dir poco, era un rischio in caso di emergenza. Sicuramente non ispirava fiducia la mattina dell’operazione, quando seguì la lettiga piangendo e torcendosi le mani e alla fine, non riuscendo a controllarsi, gridò: – E io?
Era giovane e inesperta e forse aveva inteso dire una cosa diversa, ma lui pensò che volesse dir questo: cosa sarebbe stato di lei se lui non fosse sopravvissuto?
– Una cosa per volta – le disse. – Prima lasciami morire. Poi verrò ad aiutarti a tener duro.”
Come tutti, pure il protagonista di Everyman cerca una sorta di compensazione. Qualcosa che possa dare senso a un’esistenza precaria e comunque destinata alla fine: “Se avesse mai scritto un’autobiografia, l’avrebbe intitolata « vita e morte di un corpo maschile ». Ma dopo essere andato in pensione provò a fare il pittore, non lo scrittore, e così diede questo titolo a una serie di quadri astratti.” E più avanti leggeremo: “Era come se la pittura fosse stata un esorcismo. (…) O si era messo a dipingere per cercare di liberarsi della consapevolezza che si nasce per vivere e invece si muore?”
A volte volge il pensiero al passato, come quando ricorda il padre. Quel padre che nel 1993 aveva aperto un negozio di gioielli e orologi chiamandolo “non col proprio nome ma piuttosto «Everyman’s Jewelry Store» («la gioielleria di tutti»)”. Ma anche l’inevitabile fine del padre diviene occasione per manifestare il proprio orrore di fronte alla morte. “(…) Tutt’a un tratto egli vide la bocca di suo padre come se la bara non ci fosse, come se la terra che gettavano nella fossa si depositasse su di lui, riempiendogli la bocca, accecandogli gli occhi, ostruendogli le narici e tappandogli le orecchie.”
E mentre la vita si è dipanata tra alti e bassi, tra momentanei stati di benessere e malattie invalidanti, ci si trova dinanzi alla vecchiaia e con essa – a tratti – alla consapevolezza di dover convivere con una condizione di tormentata rassegnazione. Del resto la moglie di un amico appena defunto avrà modo di dirgli: “La vecchiaia è una battaglia, caro, se non per un motivo, per un altro. È una battaglia inesorabile, e proprio quando sei più debole e meno capace di fare appello alla tua combattività.”
E più avanti lui penserà:
“La vecchiaia non è una battaglia: la vecchiaia è un massacro.”
*
Fa impressione come questo libro sia dotato nel plot e nella scrittura di semplicità e limpidezza e, al tempo stesso, di una ricchezza espositiva che lo rende unico.
Quando la letteratura riesce a raccontare senza autoincensarsi diventa davvero grande. E la vera letteratura, in fondo, è quella capace di raccontare l’uomo. L’uomo, con i suoi difetti e i suoi limiti.
Certo, non è la prima volta che la grande letteratura si confronta con il tema della morte. Il primo libro che viene in mente è senz’altro La morte di Ivan Il’ič di Lev Tolstoj. Anche questo libro affronta la tragedia della malattia con terribile minuziosità. Tuttavia, nella fase finale dell’agonia, Ivan Il’ič avrà modo di confrontarsi con la paura del trapasso. E di vincerla con il conforto della speranza. Nelle ultime righe dell’opera di Toltoj leggiamo: “Cercò la sua solita paura della morte, ma non la trovò. Dov’era? Quale morte? Non aveva alcuna paura, perché non c’era alcuna morte. Al suo posto, la luce.”
Altra considerazione. Tolstoj ci mostra i colleghi di Ivan Il’ič e la loro reazione a seguito della notizia della scomparsa. Costoro pensano alle promozioni e ai trasferimenti che scatteranno a seguito della dipartita di Il’ič e compensano la noia delle condoglianze alla vedova e del rito funebre con la gioia meschina che la morte sia capitata a un altro. In tal senso il libro svolge anche una funzione di denuncia della menzogna e dell’ipocrisia della società borghese burocratica.
Il libro di Roth si differenzia da quello di Tolstoj sia perché nel protagonista (che è ateo) non c’è la speranza di un dopo, sia perché la morte lo coglierà dispensandogli il tormento di una lucida agonia.
L’unica consolazione che il protagonista di Everyman si concede è la vicinanza ai resti dei suoi genitori quando li va a trovare al cimitero: “Vide i due nomi incisi là sopra e fu sopraffatto dallo stesso tipo di singhiozzi che assalgono i bambini piccoli e li lasciano svuotati e senza energia. Evocò facilmente l’ultimo ricordo che aveva di ciascuno dei due – il ricordo dell’ospedale – ma quando cercò di evocare il primissimo ricordo, lo sforzo che fece per spingersi più indietro che poteva nel passato che avevano in comune sollevò un’altra ondata di emozione che lo travolse.
Erano ossa e basta, ossa dentro una bara, ma le loro ossa erano le sue ossa, e lui andò a mettersi più vicino a quelle ossa che poteva, come se la vicinanza potesse unirlo a loro e mitigare l’isolamento scaturito dalla perdita del futuro e ricollegarlo a tutto quello che se n’era andato.”
Inoltre qui è assente quel cinismo che Tolstoj attribuisce ai colleghi del morto. In Everyman la storia si dipana tutta dal punto di vista del protagonista. E non c’è alcuna denuncia, così come non c’è morale. Solo la dolorosa, tremenda narrazione – e dunque la constatazione – di un’esistenza che precipita ineluttabilmente verso l’oblio.
Altro libro che viene in mente è il recente romanzo del Nobel José Saramago: Le intermittenze della morte (cosa succederebbe se, a un certo punto, non morisse più nessuno? Ai sentimenti iniziali di ovvia e festosa felicità seguirebbe il caos. Un caos che coinvolgerebbe varie organizzazioni: dal governo alle compagnie di assicurazione, dalle agenzie di pompe funebri alle case di riposo, fino alla Chiesa, giacché senza morte non c’è più resurrezione, e senza resurrezione non c’è più Chiesa). Qui la differenza è ancora più netta, sia perché il libro è fortemente allegorico, sia perché Saramago dipinge la morte come qualcosa di necessario e – per certi versi – paradossalmente utile. Almeno per alcuni.
Infine viene in mente un terzo libro che, pur non essendo esplicitamente riferibile alla morte, si può accostare a Everyman anche per via della sua crudezza. Il libro è Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway.
È anche vero però che la battaglia di Santiago contro il pesce rappresenta, in fondo, la lotta vana dell’uomo contro la morte e la vecchiaia. Il capolavoro di Hemingway, tuttavia, e qui sta la differenza principale con il libro di Roth, è un libro metaforico; mentre Everyman è scevro di ogni metafora.
Grandi libri, quelli di cui abbiamo fatto cenno. Libri testamento, per certi versi.
Tornando a Philip Roth è doveroso sottolineare che il celebre autore americano, con i suoi ventisette romanzi all’attivo, ha vinto quasi tutto quello che c’era da vincere. Nel 1997 con Pastorale americana si è aggiudicato il Premio Pulitzer per la narrativa. Nel 1998 ha ricevuto la National Medal of Arts alla Casa Bianca, Nel 2002 la Gold Medal per la narrativa (il più alto riconoscimento dell’American Academy of Arts and Letters). Ha vinto due volte il National Book Award e il National Book Critics Circe Award. Nel 2005 Il complotto contro l’America ha ricevuto il premio della Society of American Historians per il miglior romanzo storico di tematica americana nel periodo 2003-2004.
Gli manca solo il Premio dei Premi (per l’attribuzione del quale è stato più volte candidato).
Che sia la volta buona?
A essere sincero è tutt’altro che casuale il riferimento a Il vecchio e il mare. Il più celebre libro di Hemingway fu pubblicato nel 1952. Nel 1954 il suo autore ricevette il Premio Nobel per la letteratura.
Dimenticavo di sottolineare una sottile analogia. Sia Il vecchio e il mare che Everyman sono romanzi brevi.
Per motivi scaramantici è meglio non aggiungere altro. Se non che – notizia freschissima – Everyman si è appena aggiudicato il Premio Pen/Faulkner 2007.
*
Massimo Maugeri
*
*
*
EVERYMAN di Philip Roth
Traduzione di Vincenzo Mantovani
Pag. 123, euro 13,50
Einaudi, 2007
Pubblicato in SEGNALAZIONI E RECENSIONI 21 commenti »







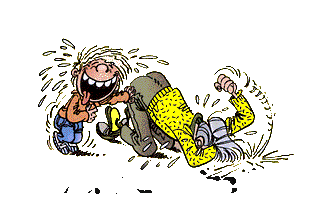

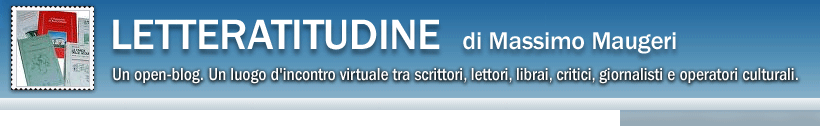




















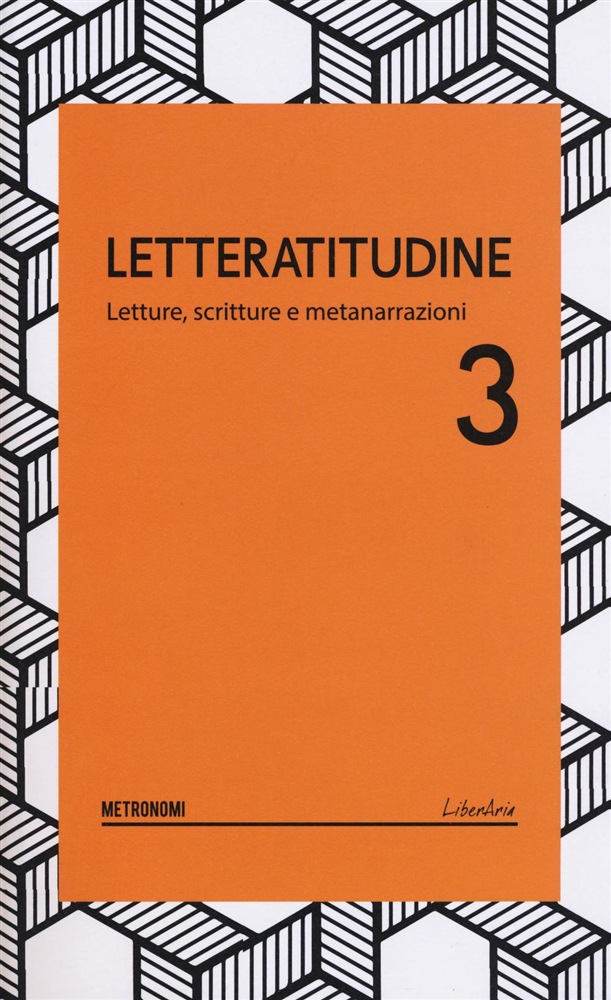





 a 25 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)
a 25 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)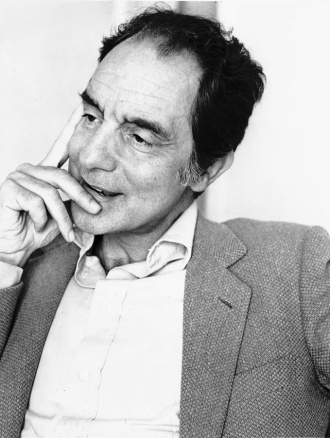 a 30 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)
a 30 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)

 ...MARIO LUZI
...MARIO LUZI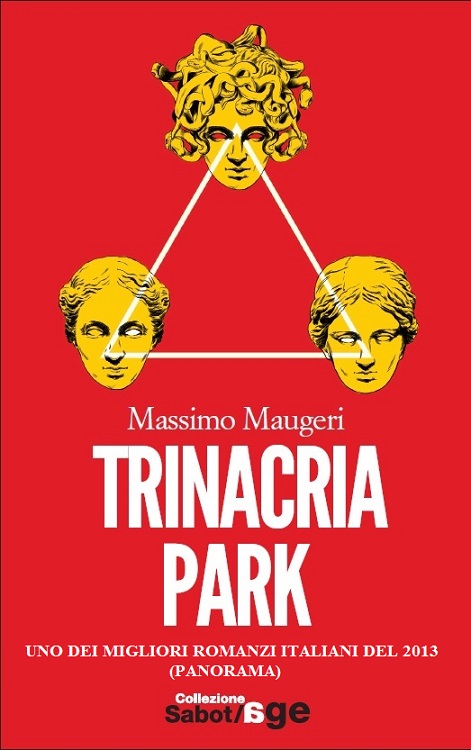
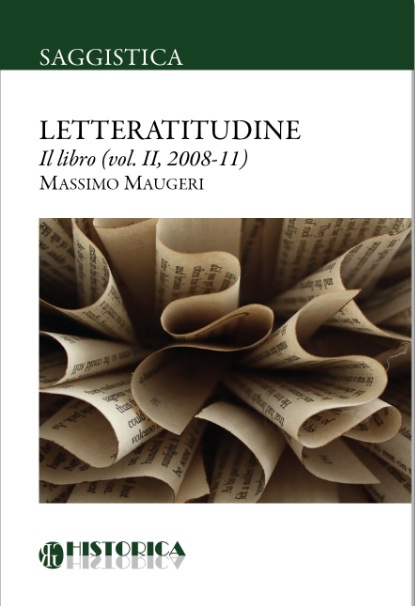


Commenti recenti