Tempo fa, in questo post, ebbi modo di accennare all’uscita di Manituana (Einaudi, 2007, pagg. 613, euro 17,50), nuovo romanzo collettivo dei Wu Ming.

Oggi approfondiamo la conoscenza di questo libro/progetto grazie all’intervista che Wu Ming 4 ha rilasciato a Giulia Gadaleta in esclusiva per Letteratitudine.
Mi piacerebbe discuterne con voi.
Per favorire il dibattito ho estrapolato alcune frasi pronunciate da Wu Ming 4 (vi invito, però, a leggere con attenzione l’intera intervista) precisando, per dirla come gli stessi Wu Ming, che questo non è un romanzo a tesi, e nemmeno un romanzo-manifesto:
- Basta sbarazzarsi delle storielle edificanti che ci hanno raccontato a scuola e immergersi nelle cronache, nelle testimonianze dirette, per rendersi conto di quanto il mito fondativo degli Stati Uniti d’America sia frutto di una grandiosa operazione ideologica.
- L’esito del conflitto fu determinato piuttosto dalla discesa in campo al fianco dei ribelli delle grandi potenze avversarie dell’Inghilterra. Molto più delle “buone ragioni storiche”, furono Francia, Spagna e Olanda, con le loro truppe, navi e casse d’oro, a garantire il successo di Washington e compagni.
- Nel romanzo un ufficiale britannico pronuncia una frase illuminante: “La guerra non è guerra finché il fratello non uccide il fratello”. Molto più che una rivoluzione, la guerra d’indipendenza fu una guerra civile, tra fratelli, cugini, cognati.
- Se proprio dovessimo trarre una qualche morale dal romanzo allora sarebbe che il rimpianto non è mai una buona ragione storica. Il rimpianto non ti porta da nessuna parte, anzi, ti porta dalla parte sbagliata, quella che perde.
- Salgari ha insegnato a noi scrittori una cosa importante, una cosa che probabilmente ha convinto molti di noi a fare quello che facciamo. E cioè che si possono raccontare storie incisive, propriamente politiche, nel linguaggio della narrativa d’avventura, cioè emozionando, divertendosi e facendo divertire.
Di seguito potrete leggere la recensione di Ibs, l’intervista di Giulia Gadaleta a Wu Ming 4 e le prime pagine del libro.
Ma prima vi invito a gustarvi il book trailer.
Ne approfitto per invitare i Wu Ming a partecipare alla discussione.
Massimo Maugeri
__________
__________
La recensione di IBS
 Il nuovo romanzo del gruppo di scrittori Wu Ming, autori di 54 e prima, col nome di Luther Blissett, del grande successo Q, segna un altro ambizioso momento di riscrittura dei grandi eventi della storia mondiale, riletti attraverso una luce nuova, mai scontata e assolutamente originale. Manituana, titolo che evoca Manitù, il Grande spirito, dio degli indiani d´America, è un romanzo ambientato a fine Settecento, un tuffo nel passato del nord America, con protagonisti i nativi che vissero la guerra di indipendenza dalla parte sbagliata.
Il nuovo romanzo del gruppo di scrittori Wu Ming, autori di 54 e prima, col nome di Luther Blissett, del grande successo Q, segna un altro ambizioso momento di riscrittura dei grandi eventi della storia mondiale, riletti attraverso una luce nuova, mai scontata e assolutamente originale. Manituana, titolo che evoca Manitù, il Grande spirito, dio degli indiani d´America, è un romanzo ambientato a fine Settecento, un tuffo nel passato del nord America, con protagonisti i nativi che vissero la guerra di indipendenza dalla parte sbagliata.
Siamo nel 1775, in una vasta estensione di terra al confine attuale tra gli Stati Uniti e il Canada, dove si trova una delle civiltà più straordinarie fiorite nel continente americano, la tollerante e “meticcia” comunità di indiani, irlandesi e scozzesi, che il suo fondatore, sir William, chiamava “Irochirlanda”. Gli Irochesi, ancora oggi studiati dagli storici come precursori dello spirito di libertà della costituzione Usa e del “melting pot” americano, costituivano una società femminista (il potere nel clan era in mano alle donne) e molto “spirituale”: era gente raffinata che, oltre a saper fare la guerra e cacciare, leggeva Voltaire, suonava il violino e aveva doti di retorica e diplomazia. Sono loro i protagonisti del romanzo, con la loro scelta di essere tra i più leali e fedeli combattenti a sostegno della Corona britannica sia contro i Francesi, nella conquista del Canada, e sia contro i coloni ribelli dalla cui insurrezione sarebbero nati gli Stati Uniti d´America. È la guerra a mandare in frantumi quel mondo di pace. La lega delle Sei nazioni, che riuniva le maggiori tribù degli Irochesi, deve scegliere se combattere, e con chi schierarsi. Il capo di guerra irochese, Thayendanega, sceglierà di condurre il suo popolo lontano, oltre il mondo che ha sempre conosciuto e, qui il romanzo rovescia l’immagine canonica del pellerossa, si alleerà con re Giorgio contro i coloni che gli rubano la terra. Thayendanega diventerà noto come Joseph Brant e molti dei più grandi capi irochesi si chiameranno con nomi europei: non erano affatto “selvaggi”, se non nel senso che in guerra, all’occorrenza, utilizzavano metodi del tipo di quelli che il generale Washington avrebbe poi ordinato nei loro confronti: vale a dire bruciare, scotennare, sterminare.
Un romanzo epico, frutto di un grande lavoro collettivo, ricco di effetti speciali, con molta azione. Otto anni fa i Wu Ming, che si firmavano ancora Luther Blissett, per spiegare come si fa a scrivere in gruppo, usarono questa immagine: “È come per il jazz: grande affiatamento, arrangiamenti collettivi e assoli individuali”.
__________
Intervista realizzata da Giulia Gadaleta
Nel 1775 nel territorio che va dall’attuale Stato di New York alla Pennsylvania le sei nazioni irochesi -Mohawk, Oneida, Cayuga, Onondagam, Seneca e Tuscarora – convivono prosperosamente con i coloni. Hanno combattuto la guerra franco-inglese al loro fianco e l’alleanza con sua maestà britannica ha favorito scambi commerciali ma anche convivenza e integrazione delle due comunità. Quando questa comunità meticcia resta orfana di Sir William Johnson Warraghiyagey, Commissario per gli Affari Indiani, la situazione precipita: è l’alba della rivoluzione che genererà gli Stati Uniti d’America.
Ho intervistato Wu Ming 4 in occasione della selezione di Manituana nella terzina finalista del Premio di letteratura avventurosa Emilio Salgari .
Come è nato Manituana? Quali suggestioni l’hanno messo in moto? Manituana è costruito intorno ad alcuni eventi e figure storiche realmente esistite, che fonti c’erano a questo proposito?
WM: Il romanzo nasce da una suggestione forte per la storia americana e statunitense in particolare. Gli Stati Uniti sono il paese che più di ogni altro influenza e incarna l’immaginario occidentale. Per capire la crisi attuale del cosiddetto “impero americano” abbiamo deciso di provare a raccontarne l’origine, liberandola dalla mitografia. Per farlo abbiamo scelto un punto di vista inusuale e che non si è soliti associare alla guerra d’Indipendenza, cioè quello dei nativi. In particolare quello delle Sei Nazioni irochesi, che vennero coinvolte e travolte da quel conflitto. Il materiale a disposizione è tanto, grazie al fatto che nel mondo anglosassone esiste una grande tradizione di accessibilità alle fonti primarie. Basta sbarazzarsi delle storielle edificanti che ci hanno raccontato a scuola e immergersi nelle cronache, nelle testimonianze dirette, per rendersi conto di quanto il mito fondativo degli Stati Uniti d’America sia frutto di una grandiosa operazione ideologica. Nel nostro immaginario ci sono indiani che cacciano bisonti e vanno a cavallo: è l’immagine ottocentesca tramandata dai fumetti e dal cinema western e fa riferimento al periodo successivo a Manituana.
Cinema e fumetti hanno avuto un ruolo nello scrivere Manituana e se sì ci fai dei titoli?
WM: Per quanto riguarda i fumetti direi il Comandante Mark (per i membri del collettivo un po’ più grandicelli); ma soprattutto i volumi “americani” di Hugo Pratt, come Ticonderoga e Wheeling. Il cinema hollywoodiano ha affrontato poco e male la guerra d’Indipendenza e già questo è un fatto curioso, forse anche rivelatore di una certa cattiva coscienza. A fronte di decine di film ambientati durante la guerra di Secessione, se ne possono rintracciare davvero pochi sulla Rivoluzione americana (e quasi nessuno valido). Per quanto riguarda poi la questione nativa, in generale il cinema se n’è occupato in relazione alla conquista del West. Così è facile dimenticarsi che la grande corsa verso ovest è preceduta da due secoli e mezzo di storia condivisa.
In effetti i film che più ci hanno influenzato nella scrittura di Manituana non hanno direttamente a che fare con gli eventi del romanzo. Quello che ci si avvicina di più è L’Ultimo dei Mohicani di Michael Mann, ambientato durante la guerra anglo-francese, precedente di vent’anni la Rivoluzione. Poi direi Manto Nero, un film canadese che si ambienta nel XVII secolo e racconta la storia di un missionario gesuita mandato tra gli irochesi. Infine The New World, di Malick, che addirittura parla dei primi contatti tra coloni inglesi e nativi.
Sono pellicole che riescono a dare un’idea dell’impatto che la colonizzazione ebbe sulle popolazioni native americane e del complesso equilibrio che si sviluppò nei primi secoli della conquista.
Mi sembra che la tesi del romanzo sia che la nascita della nazione americana sia legata all’abbattimento dei confini, sia in senso fisico (la frontiera) sia in senso sociale. E’ così? In questo senso si può considerare Manituana un romanzo morale?
WM: Onestamente non lo so. Noi non scriviamo romanzi a tesi. Manituana racconta l’avventura di un clan famigliare meticcio, composto da europei e nativi, che scelgono di combattere dalla parte del re inglese per salvarguardare se stessi, i propri beni e il proprio potere. Racconta anche di come vennero spazzate via nazioni indiane dalla storia millenaria, tutt’altro che primitive e ingenue, ma che convivevano con gli europei da secoli in un sistema di interscambio reciproco, fatto di commerci, alleanze, matrimoni, viaggi diplomatici. E’ un fatto che una delle cause scatenanti della Rivoluzione fu la pressione dei coloni sui confini stabiliti dalla Corona britannica. Per blandi che fossero, quei confini salvaguardavano ancora le terre indiane. Così come è indubbio che l’Indipendenza abolì la nobiltà di nascita e il potere aristocratico sul suolo americano. Non per questo però fu una rivoluzione di classe, come sarebbe stata quella francese. Soltanto una minoranza dei coloni europei si schierò apertamente per una o per l’altra fazione e i pochi che lo fecero si divisero equamente tra le due parti in lotta. L’esito del conflitto fu determinato piuttosto dalla discesa in campo al fianco dei ribelli delle grandi potenze avversarie dell’Inghilterra. Molto più delle “buone ragioni storiche”, furono Francia, Spagna e Olanda, con le loro truppe, navi e casse d’oro, a garantire il successo di Washington e compagni. Ma questa è un’altra delle cose che non si possono dire se si vuole mantenere intatto il mito originario americano. Nei prossimi romanzi vogliamo occuparci specificamente di questo aspetto “globale” della guerra d’Indipendenza.
Rispetto a vostri precedenti romanzi, questo è un romanzo storico in senso stretto, che segue un arco temporale lineare. Non ci sono salti in avanti e indietro. Avete voluto anche qui illuminare le ombre del passato, i passaggi oscuri? Quanto vi siete affidati all’invenzione?
WM: L’andamento lineare della trama è dovuto alla scelta di riprodurre la dimensione del viaggio. In effetti si tratta di un andamento classico: anabasi e catabasi. La prima e la seconda parte narrano il viaggio dalla periferia alla capitale dell’impero; nella terza c’è il ritorno degli eroi e il dispiegarsi della guerra… per poi affrontare un nuovo esodo. Tra i protagonisti soltanto due sono inventati: Philip Lacroix ed Esther Johnson. Tutti gli altri sono storicamente vissuti, ma ovviamente noi li abbiamo interpretati a modo nostro, secondo il nostro sguardo. Se ci riferiamo agli eventi storici e biografici, quindi, di inventato in senso stretto c’è molto poco.
Alla guerra d’indipendenza americana voi attribuite il ruolo di spartiacque: dove prima c’era un sistema di regole che permetteva la convivenza dopo c’è il caos, dove c’era il meticciato dopo c’è la segregazione e lo sterminio, dove prima c’era una guerra regolamentata dopo c’è una guerra senza regole (a un certo punto uno dei personaggi commenta che tra uomini che diffidano l’uno dell’altro, non può esserci altro che una guerra senza regole). Il lettore può restare disorientato e pensare che siete dei nostalgici del colonialismo inglese…
WM: Qualcuno ha provato a farci passare per tali, in effetti… ma temo che si tratti di lettori distratti, per non dire in malafede. Da un certo punto di vista basterebbe pensare alla parte centrale del romanzo, dove la società londinese dell’epoca viene vivisezionata strato per strato, per togliersi ogni dubbio su quanta simpatia possiamo nutrire per l’impero britannico. Ma la verità è che la faccenda è più complessa. I protagonisti di Manituana, bianchi e indiani, sono lealisti, fedeli al re. Rimpiangono la pace che regnava prima della ribellione delle colonie, rimpiangono la scomparsa di Sir William Johnson, lo scaltro amministratore della Corona che governava la valle del fiume Mohawk come un magnanimo padre-padrone. Insomma rimpiangono ciò che non c’è più, e come spesso accade a chi si lascia prendere dalla nostalgia, lo idealizzano. E’ attraverso i loro occhi che il lettore vede quel passato, questo è vero. Ma a leggere bene, quel passato era tutt’altro che perfetto, dato che portava in sé i germi del presente che i protagonisti si trovano a vivere. Ad esempio portava in grembo l’invidia e il rancore dei piccoli coloni, ultimi arrivati, nei confronti dei grandi latifondisti come i Johnson. Gente che se n’era andata dall’Europa per sfuggire alle vessazioni dei nobili e se li ritrovava anche in America col beneplacito di Sua Maestà. Un aspetto questo che nel romanzo emerge con forza fin dal primo capitolo. Per non parlare della concentrazione del potere politico ed economico nella stessa persona, morta la quale, rimane un vuoto difficilmente colmabile. La concezione dinastica e familista del potere, come insegna Shakespeare, è sempre foriera di faide e guerre fratricide. Nel romanzo un ufficiale britannico pronuncia una frase illuminante: “La guerra non è guerra finché il fratello non uccide il fratello”. Molto più che una rivoluzione, la guerra d’indipendenza fu una guerra civile, tra fratelli, cugini, cognati. Manituana racconta anche questo e non fa sconti a nessuna delle due parti in campo: le efferatezze compiute dai lealisti filo-britannici non hanno niente da invidiare a quelle messe in atto dai ribelli, perché sono le stesse persone, figlie della stessa cultura, e condividono lo stesso odio. In definitiva direi che se proprio dovessimo trarre una qualche morale dal romanzo allora sarebbe che il rimpianto non è mai una buona ragione storica. Il rimpianto non ti porta da nessuna parte, anzi, ti porta dalla parte sbagliata, quella che perde. Perché, come diceva il pistolero di Il mio nome è Nessuno, “i bei tempi non sono mai esistiti”. E’ per questo che i nostri eroi sono destinati alla sconfitta senza possibilità d’appello. Se ritroveranno un principio di speranza sarà solo grazie all’idea tutta femminile, portata in seno dalle matriarche della nazione, che tra uccidere e morire esiste sempre una terza via: vivere.
La sfumatura è sottile, ma, come ho detto, noi non scriviamo romanzi-manifesto. Certo sarebbe stato più facile far vedere un Sir William Johnson cattivo, più simile al corrispettivo James Brooke salgariano, e magari i piccoli laboriosi coloni che chiedono agli amici indiani di insegnare loro le tecniche di guerriglia nei boschi, per combattere le perfide giubbe rosse. Così l’ordine delle cose come ci sono state raccontate sarebbe stato mantenuto e le anime belle avrebbero dormito sonni tranquilli. Purtroppo però le cose sono più complesse di così. E a noi le storie complesse piacciono, sono sfide narrative, mentre ci interessa poco il manicheismo di certe visioni ideologiche.
Siete arrivati in finale al premio di letteratura avventurosa Emilio Salgari. Che rapporto c’è tra la vostra scrittura e l’autore de Le tigri di Mompracem? I personaggi di Salgari come il Corsaro Nero e Sandokan sopravvivono al tempo e fanno parte stabilmente del nostro immaginario: si può ancora scrivere letteratura d’avventura e in che senso? Oppure quello che facciamo oggi è ri-scrivere? Ha un rapporto con lo scrivere in gruppo e con il pubblicare in copyleft?
WM: Parto dall’assonanza particolare, strettamente connessa a Manituana. Salgari è stato il primo narratore popolare a stigmatizzare il colonialismo europeo come nefasto e liberticida. Tuttavia mentre trasformava in eroi i pirati e i fuorilegge che resistevano all’impero britannico o spagnolo, non difendeva né il purismo etnico né – diremmo oggi – il relativismo culturale. Basta pensare al ciclo indo-malese, completamente costellato di unioni miste. Sandokan e Marianna, Tremal-Naik e Ada, Yanez e Surama (unioni queste ultime due dalle quali nascono figli meticci), o ancora Darma e Sir Moreland. Credo che per l’epoca in cui si trovava a vivere, questa sia stata l’intuizione più incredibile di Salgari. E cioè che al di là delle giuste guerre di liberazione dal colonialismo, lo scontro di civiltà sarebbe stato superato dalla creazione di una civiltà ulteriore, meticcia, plurale, comunque basata sulla possibilità di convivenza tra diversi. In secondo luogo Salgari ha insegnato a noi scrittori una cosa importante, una cosa che probabilmente ha convinto molti di noi a fare quello che facciamo. E cioè che si possono raccontare storie incisive, propriamente politiche, nel linguaggio della narrativa d’avventura, cioè emozionando, divertendosi e facendo divertire. Questa consapevolezza gli derivava direttamente dalla tradizione del fouilleton francese e – ancora prima – dal romanzo settecentesco europeo. E’ una lezione fondamentale. E’ ciò che ci fa assimilare Sandokan e il Corsaro Nero a Ho Chi Minh o Che Guevara. Con la differenza che, al contrario dei personaggi storici, la Tigre della Malesia e il conte di Ventimiglia non potranno mai deluderci.
Mi chiedi se si potrà sempre scrivere narrativa d’avventura o se piuttosto non facciamo altro che ri-scrivere. A nostro avviso non si tratta di opzioni contrapposte. In parte non facciamo che rideclinare gli stessi temi narrativi dalla notte dei tempi (anche Salgari lo faceva); in parte, quando siamo bravi, riusciamo a plasmare la stessa materia narrativa in nuove forme, attuali ed efficaci. Alla base di una scelta come quella del copyleft c’è proprio la convinzione che le storie siano un fiume inesauribile, patrimonio inalienabile dell’umanità. La sorgente si trova in una grotta sotto il cielo del paleolitico, la foce è un punto ideale sull’orizzonte. Da questo punto di vista non è corretto che qualcuno raccolga un po’ di quell’acqua in una bottiglia stabilendo che è soltanto “sua”. Le storie sono di tutti e tali devono rimanere. Noi siamo convinti di questo e quindi rendiamo liberi i diritti di riproduzione dei nostri scritti, a condizione che restino tali e nessun altro provi ad appropriarsene o a trarne profitto. In questo modo salvaguardiamo i proventi del nostro lavoro e consentiamo alle storie di circolare liberamente.
___________
Giulia Gadaleta è nata nel 1972. Vive a Bologna. Fa la bibliotecaria e la giornalista. Collabora con Pulp libri, Il tamburo e carmillaonline.com. E’ ideatrice e conduttrice di Mompracem, settimanale avventuroso di letteratura, un magazine settimanale in onda su Radio Città del Capo.
Da un pò di tempo ha inziato una esperienza di lettura in carcere.
__________
__________
LE PRIME PAGINE DI “MANITUANA” (in copyletf dal sito Manituana)
Prologo
Lago George, colonia di New York, 8 settembre 1755.
I raggi del sole incalzavano il drappello, luce di sangue filtrava nel bosco.
L’uomo sulla barella strinse i denti, il fianco bruciava. Guardò in basso, gocce scarlatte stillavano dalla ferita.
Hendrick era morto e con lui molti guerrieri.
Rivide il vecchio capo bloccato sotto la mole del cavallo, i Caughnawaga che si avventavano su di lui.
Gli indiani non combattevano mai a cavallo, ma Hendrick non poteva più correre né saltare. Avevano dovuto issarlo sull’arcione. Quanti anni aveva? Gesù santo, aveva incontrato la regina Anna. Era Noè, Matusalemme.
Era morto combattendo il nemico. Una fine nobile, persino invidiabile, se solo si fosse trovato il cadavere per dargli sepoltura cristiana.
William Johnson lasciava andare i pensieri, un volare di rondini, mentre i portatori marciavano lungo il sentiero. Non voleva chiudere gli occhi, il dolore lo aiutava a stare sveglio. Pensò a John, il primogenito, ancora troppo giovane per la guerra. Suo figlio avrebbe ereditato la pace.
Voci e schiamazzi segnalarono l’accampamento. Le donne strillavano e inveivano, domandavano di figli e mariti.
Lo deposero dentro la tenda.
– Come vi sentite?
Riconobbe il viso arcigno e gli occhi grigi del capitano Butler. Tentò di sorridere, ottenne solo una smorfia.
– Ho l’inferno nel fianco destro.
– Segno che siete vivo. Il dottore sarà qui a momenti.
– I guerrieri di Hendrick?
– Li ho incontrati mentre tornavo qui. Scalpavano cadaveri e feriti, senza distinzione.
William reclinò il capo sul giaciglio e prese fiato. Aveva dato la sua parola a Dieskau: nessuno avrebbe infierito sui prigionieri francesi. Hendrick aveva strappato la promessa ai guerrieri, ma Hendrick era morto.
Un uomo basso entrò nella tenda, paonazzo, chiazze di sudore sulla giacca.
William Johnson sollevò la testa.
– Dottore. Ho qui una rogna per voi.
Il medico gli sfilò la giubba, aiutato dal capitano Butler. Tagliò le brache con le forbici e prese a lavare e tamponare la ferita.
– Siete fortunato. La pallottola ha toccato l’osso ed è rimbalzata via.
– Sentito, Butler? Respingo i proiettili.
Il capitano borbottò un ringraziamento a Dio e offrì uno straccio a William, perché potesse morderlo mentre il medico cauterizzava la ferita.
– Non alzatevi. Avete perso molto sangue.
– Dottore… – William aveva il volto teso e slavato, la voce era un rantolo. – I nostri uomini stanno conducendo al campo i prigionieri francesi. Tra loro c’è un ufficiale, il generale Dieskau. È ferito, forse privo di sensi. Vorrei che gli prestaste le vostre cure. Capitano, accompagnate il dottore.
Butler e il medico fecero per dire qualcosa, ma William li anticipò: – Posso restare da solo. Non morirò, ve l’assicuro.
Butler annuì senza dire nulla. I due si congedarono. Per impedirsi di svenire, William tese le orecchie e concentrò il pensiero sui rumori.
Vento a scrollare i rami.
Richiami di corvi.
Grida lontane.
Grida più vicine.
Grida di donne.
Un trambusto improvviso attraversò il campo. William pensò fosse Butler di ritorno con i prigionieri.
Guardò fuori dalla tenda. Un gruppo di guerrieri Mohawk: urlavano e piangevano, i tomahawk alti sopra le teste. Trascinavano i Caughnawaga con una corda al collo, le mani legate dietro la schiena. Le donne del campo li vessavano con calci, pugni e lanci di pietre.
Il drappello si fermò a non più di trenta iarde. Nessuno dei guerrieri guardò verso la tenda: erano dimentichi di tutto, ogni senso teso alla vendetta. Il più agitato si muoveva avanti e indietro.
– Non siete uomini. Siete cani, amici dei Francesi! Hendrick vi aveva detto di non alzare le armi contro i vostri fratelli! Vi aveva avvertiti!
Afferrò un prigioniero per i capelli, lo trascinò in ginocchio e recise lo scalpo. Quello cadde nella polvere, prese a urlare e contorcersi. Le donne lo finirono a bastonate.
William sentì il sudore gelare la pelle.
Un secondo prigioniero venne scotennato, le donne lo presero a calci prima di pugnalarlo a morte.
William pregò che tra i morituri non vi fossero bianchi. Finché rimaneva una questione tra indiani, poteva risparmiarsi di intervenire.
Hendrick era morto. Figli e fratelli erano morti. I Mohawk avevano diritto alla vendetta, purché non toccassero i Francesi: servivano per gli scambi di ostaggi.
Il terzo Caughnawaga crollò a terra con il cranio sfondato.
Al quartier generale di Albany i caporioni mandati dall’Inghilterra non volevano capire. Non si poteva combattere come in Europa. I Francesi scatenavano le tribù contro i coloni inglesi. Incursioni, incendi e saccheggi. Petite guerre, la chiamavano. I Francesi avevano un nome per ogni cosa. All’alto comando britannico serviva lo stomaco di reagire con la stessa moneta. Era in gioco il dominio su un intero continente.
L’arrivo di nuovi prigionieri interruppe le riflessioni. Civili bianchi, furieri, maniscalchi e soldati con la divisa lacera. Uno dei guerrieri trascinò fuori dal gruppo un ragazzo. Indossava l’uniforme da tamburino del reggimento.
William era spossato. Coglieva a fatica le parole, ma la sorte del ragazzino era chiara. Un altro guerriero affrontò il primo, che già mostrava il coltello.
Con le penne sul capo e il corpo dipinto, ricordavano due galli in un’arena.
– Porta la divisa dei francesi. Non puoi prendere il suo scalpo!
– L’ho sentito parlare caughnawaga.
– Hendrick ha detto che i prigionieri bianchi spettano ai padri inglesi.
– Guardalo in faccia, ti sembra un bianco?
– Se Hendrick fosse qui ti scaccerebbe.
– Io voglio vendicarlo.
– Tu lo disonori.
– Vuoi aspettare che cresca e diventi un guerriero? Meglio ucciderlo subito, ora che i traditori Caughnawaga sono in fuga e ci temono.
– Stupido! Warraghiyagey si infurierà con te.
William Johnson sentì scandire il proprio nome indiano. Warraghiyagey, «Conduce Grandi Affari». Fece leva sui gomiti, doveva intervenire.
Vide il coltello calare sulla chioma del tamburino. Riempì i polmoni per gridare.
Qualcosa colpì il guerriero al volto.
La pietra rimbalzò per terra. L’uomo lasciò la presa, portò la mano alla bocca, tossì, sputò sangue. Una sagoma piccola e veloce gli fu addosso e lo spinse via.
Un guizzo di pelle di cervo e capelli corvini. Ruggiva contro i guerrieri, che arretravano interdetti.
– Siete senza onore, – gridò la giovane donna. – Dite di voler vendicare Hendrick, ma è il denaro degli Inglesi che volete, dieci scellini per ogni scalpo indiano!
Si avvicinò al guerriero che ancora stringeva il pugnale e gli sputò addosso. L’uomo avrebbe voluto colpirla, ma lei lo incalzò.
– È poco più di un bambino. Non ha sparato un colpo. Potrebbe avere l’età di mio fratello –. Indicò un ragazzo dall’aria attenta, al margine del cerchio di donne che si era radunato intorno alla scena. – Quando avrete incassato la paga, la spenderete per comprarvi il rum. Quelli che oggi si dànno arie da grandi guerrieri, domani rotoleranno nel fango come porci.
Il guerriero le indirizzò un gesto di sdegno prima di ritirarsi.
La donna si rivolse agli altri. – Non pensate che agli scalpi, ma gli scalpi non vanno a caccia, non portano a casa il cibo, non coltivano gli orti. Siete tanto ubriachi di sangue da calpestare le nostre usanze? Oggi molte donne hanno perso figli e mariti. Vanno risarcite con nuove braccia –. Guardò il giovane tamburino dall’alto in basso. – Dobbiamo adottare i prigionieri come nuovi figli e fratelli, secondo la tradizione. La madre di mia madre fu adottata, veniva dai Grandi Laghi. Lo stesso Hendrick divenne un Mohawk in questo modo. Voi lo avreste ucciso!
Le donne si spostarono alle spalle della giovane. Insieme fronteggiarono i guerrieri. Gli uomini scambiarono occhiate incerte, poi si allontanarono con finta indifferenza e molti borbottii.
William Johnson si abbandonò sulla branda.
Conosceva quella furia, l’aveva vista bambina.
Molly, figlia del sachem Brant Canagaraduncka.
Da sola teneva testa ai guerrieri.
Decideva la sorte di un prigioniero.
Parlava come avrebbe fatto Hendrick.
- – - – - – - – - – - - -
Prima parte
Irochirlanda
1775
1.
Avevano portato anche i bambini, perché un giorno lo raccontassero a figli e nipoti. Dopo molti tentativi, l’asta finì per mettersi dritta. Il Palo della Libertà.
Un tronco di betulla, pulito e levigato alla buona. Un groviglio di corda. Un rettangolo di stoffa rossa tagliato da una coperta. La bandiera del Congresso continentale.
Il comitato di sicurezza di German Flatts approvava il suo primo documento: l’adesione alle rimostranze che l’Assemblea di Albany aveva inviato al Parlamento inglese. Il pastore Bauer ne diede lettura. Il testo si concludeva con l’impegno solenne a «stare uniti, nei valori della religione, dell’onore, della giustizia e dell’amore per la Patria, allo scopo di non essere mai schiavi e difendere la propria libertà a costo della vita».
Il vessillo si preparava a salire, salutato da canti e preghiere, quando un rumore di zoccoli interruppe la cerimonia.
Una squadra di cavalieri apparve sul sagrato. Brandivano sciabole, fucili e pistole. Qualcuno sparò in aria, mentre la piccola folla cercava riparo tra le case. Restarono sullo spiazzo pochi coraggiosi. Teste impaurite facevano capolino da dietro i muri, negli spiragli delle porte e alle finestre della taverna. Un nome volò da una bocca all’altra, in un girotondo di voci.
Il nome dell’uomo che aveva fatto fuoco contro il cielo.
Sir John Johnson.
Intorno a lui, gli uomini del Dipartimento per gli Affari indiani. I suoi cognati Guy Johnson e Daniel Claus. Subito dietro, il capitano John Butler e Cormac McLeod, scherano dei Johnson e capo dei fittavoli scozzesi che lavoravano la terra del baronetto.
Mancava soltanto il vecchio patriarca del clan, Sir William, eroe della guerra contro i Francesi, signore della valle del Mohawk, morto l’anno prima.
Sir John montava un purosangue baio dal pelo lucido, fremente sotto la stretta del morso. Si sfilò dal gruppo e prese a cavalcare lungo il perimetro dello spiazzo, mentre fissava i membri del comitato con aria sprezzante, uno dopo l’altro.
Guy Johnson portò il cavallo a ridosso di una tettoia e si arrampicò là sopra con difficoltà, per via della stazza.
– Forza, siamo qui per discutere, – disse alle case. – È questo che volete, no?
Nessuno fiatava. Sir John diede uno strattone alle briglie, il cavallo arretrò e ruotò su se stesso, fino a cedere alla volontà del padrone.
Allora qualcuno si fece coraggio. Il gruppo che fronteggiava gli uomini a cavallo si infoltì.
Guy Johnson lanciò un’occhiata severa.
– Indirizzare una petizione al Parlamento è lecito, ma issare una bandiera che non sia quella del re è sedizione. Una cosa vi copre di ridicolo, l’altra manda sulla forca.
Ancora silenzio. I membri del comitato evitavano di guardarsi per timore di cogliere un cedimento negli occhi dei compagni.
– Volete seguire l’esempio dei Bostoniani? – riprese Guy Johnson. – Due fucilate all’esercito del re e si sono montati la testa. Sua Maestà possiede la flotta più potente del mondo. È buon amico degli indiani. Controlla tutti i forti dal Canada alla Florida. Credete che i ribelli del Massachusetts otterranno molto più di un cappio al collo?
Fece una pausa, quasi volesse sentire il sangue ribollire nelle vene dei tedeschi.
– La famiglia Johnson, – proseguì calmo, – possiede terra e commercia più di tutti voi messi assieme. Saremmo i primi a stare dalla vostra parte, se davvero Sua Maestà minacciasse il diritto di fare affari.
Una voce risuonò forte: – I vostri affari non li minaccia di certo. Voi siete ricco e ammanicato. Le tasse del re strozzano noialtri.
Un coro d’assensi accolse quelle parole. Dalla cima della tettoia Guy Johnson individuò Paul Rynard, il bottaio. Una testa calda.
Lo stallone di Sir John scrollò il capo e sbuffò nervoso, rimediando un altro strattone.
Il frustino del baronetto colpì il cuoio dello stivale.
– Le tasse servono a mantenere l’esercito, – ribatté Guy Johnson. – L’esercito mantiene l’ordine nella colonia.
– L’esercito serve a voialtri per continuare a tenerci sotto! – sbottò Rynard.
Gli animi si accesero, qualcuno dei cavalieri alzò d’istinto le armi, ma un cenno di Sir John li trattenne.
– Non ancora, – sibilò il baronetto.
Guy Johnson, rosso in volto, strillò dall’alto: – Quando i Francesi e i loro indiani minacciavano le vostre terre, l’esercito lo chiedevate a gran voce! La pace vi ha reso arroganti e stupidi al punto da desiderare un’altra guerra. Fate molta attenzione, ai morti la libertà non serve.
– Ci state minacciando! – gridò Rynard.
– Tornatene in Irlanda dai tuoi amici papisti! – urlò qualcuno. Un sasso scagliato verso Guy Johnson lo mancò di poco.
Una smorfia di compiaciuto disprezzo segnò la faccia di Sir John: – Adesso.
I cavalli mossero in avanti, il comitato di sicurezza si sciolse seduta stante. Gli uomini corsero in tutte le direzioni.
Il cavallo di John Butler travolse Rynard e lo fece rotolare nel fango. Il bottaio si rialzò, cercò scampo verso la chiesa, ma Sir John gli sbarrò il passo. Il baronetto lo frustò con quanta forza aveva. Rynard si accucciò a terra, le mani sulla faccia. Tra le dita, vide McLeod sguainare la sciabola e partire al galoppo. Strisciò via, invocando la misericordia di Dio. Quando ricevette il colpo di piatto sul fondoschiena, urlò forte, tra le risate roche dei cavalieri.
Mentre Rynard si scopriva ancora vivo, gli uomini del Dipartimento si radunarono al centro dello spiazzo. Guy Johnson rimontò in sella e li raggiunse.
Un leggero colpo di speroni e Sir John fu sotto il Palo della Libertà.
Parlò in modo che tutti lo sentissero, dovunque fossero rintanati.
– Ascoltate bene! Chiunque in questa contea voglia sfidare l’autorità del re, dovrà vedersela con la mia famiglia e con il Dipartimento indiano –. I suoi occhi maligni parvero scovare gli abitanti uno a uno, oltre le finestre buie. – Lo giuro sul nome di mio padre, Sir William Johnson.
Sfilò un piede dalla staffa. Dopo un paio di calci, il Palo rovinò nel fango.
Tempo fa Enrico Manca, nel ruolo di Presidente della Rai, marchiò Pippo Baudo con l’epiteto di nazionalpopolare.







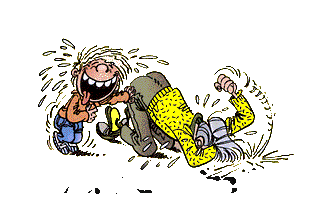

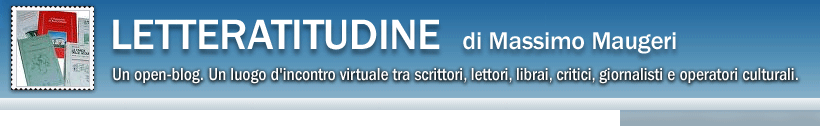

 Senzaterra
Senzaterra
















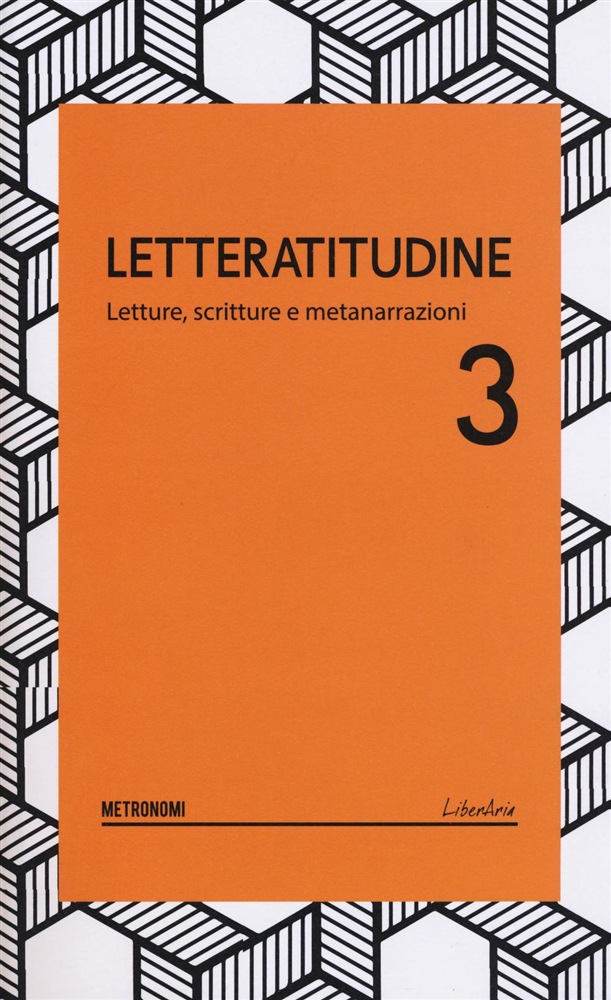





 a 25 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)
a 25 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)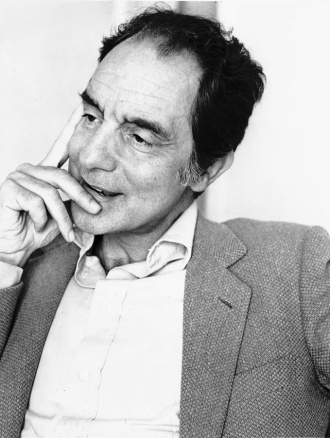 a 30 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)
a 30 anni dalla morte
(partecipa con un tuo commento)

 ...MARIO LUZI
...MARIO LUZI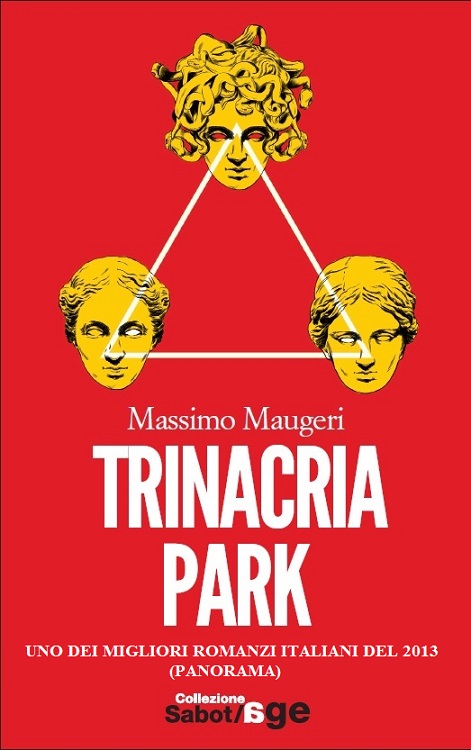
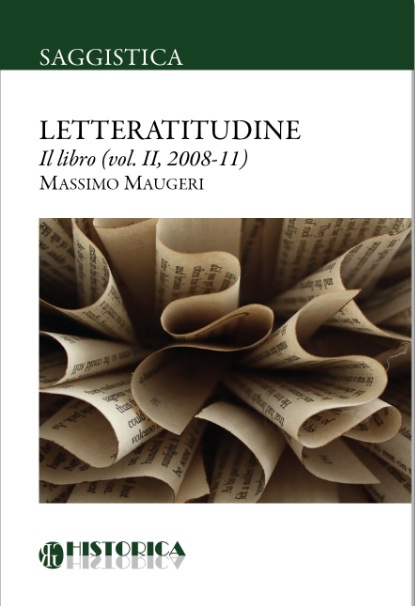


Commenti recenti